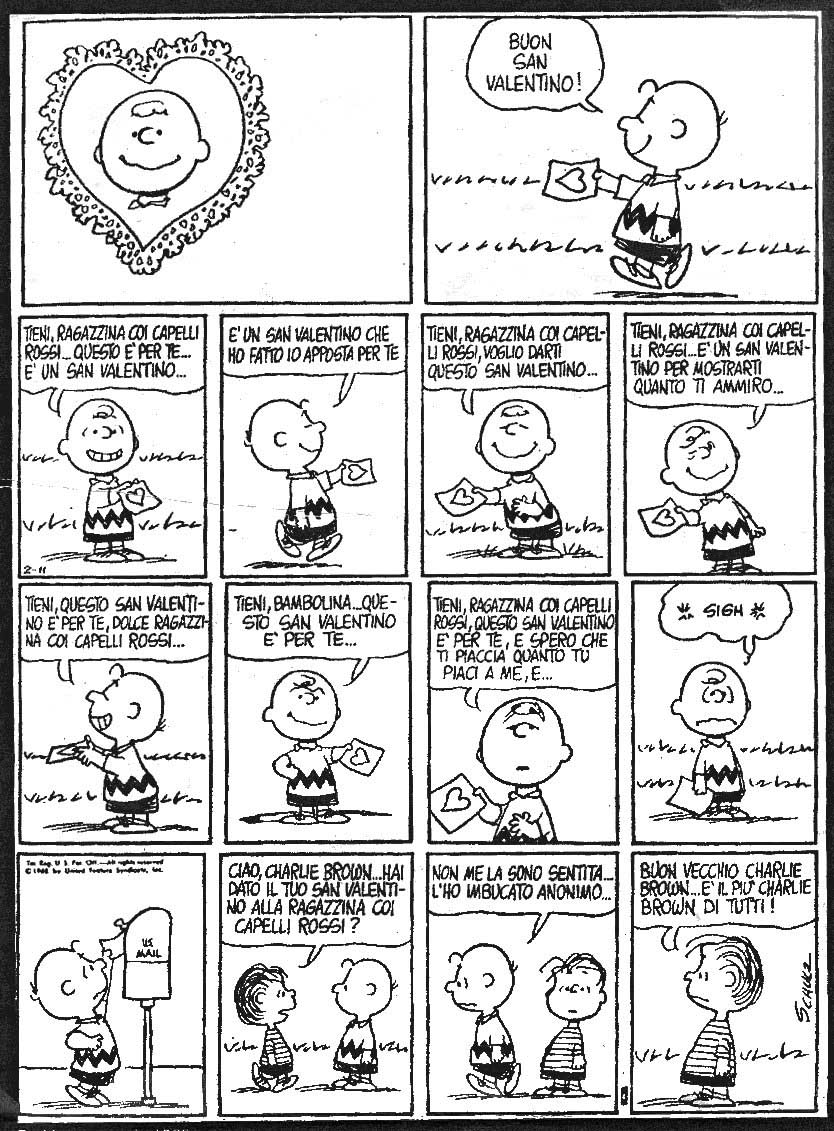|
PREMESSA (chissà
perché c’è sempre una premessa…)
Io credo che il mettersi a scrivere
davanti ad una tastiera o seduti ad una scrivania o dove volete voi, sia
soprattutto un atto di presunzione perché chi scrive crede di aver
assunto una posizione di privilegio rispetto agli altri nel vedere,
sentire e capire un certo soggetto o oggetto di discussione.
In realtà scrivere è un po’ come trovarsi nella stanza degli
specchi, guardarsi attorno e vedere riflessa la propria immagine in una
combinazione infinita di immagini distorte. Quello che scriviamo,
dunque, non è altro che un parto della nostra fantasia, un’invenzione
espressa con le parole, un’immagine riflessa da uno specchio, un
aspetto o un possibile aspetto di noi stessi.
Eppure la scrittura è stata, fin dal momento della sua invenzione,
veicolo di emozioni, sensazioni, drammi, lacrime, risate, pensieri e
quant'altro siamo in grado di vivere nella monotonia della vita di tutti
i giorni.
Già… e questo potete immaginare bene cosa significhi. Significa che
davvero in quello che scriviamo, o leggiamo, realtà e fantasia sono le
due facce della stessa medaglia ma significa anche che domani non
possiamo sperare di trovare nulla di più di quello che saremo stati
capaci di inventare e di sognare.
Quando mi è saltata in mente l'idea di farvi leggere qualcosa del
sottoscritto è stato come entrare nella stanza degli specchi, scegliere
due immagini o possibili immagini di me stesso e ciò che son riuscito a
scorgere tra riflessi ingannevoli e voli di fantasia e provare a
spiaccicarvele sotto gli occhi. Non provate, però, ad immaginare quale
sia quella giusta (ammesso che ce ne sia una): non potreste saperlo.
Mi vengono in mente, infatti, le parole del mio amatissimo Italo
Calvino, il quale alla domanda su chi fosse in realtà il Calvino
scrittore ed in quale libro o scritto si rispecchiasse di più, rispose
così: "Chiedetemi tutto ciò che volete ed io vi risponderò: ma
non vi dirò mai la verità."
un re in ascolto (Yahoo Italia)
20/09/01 |
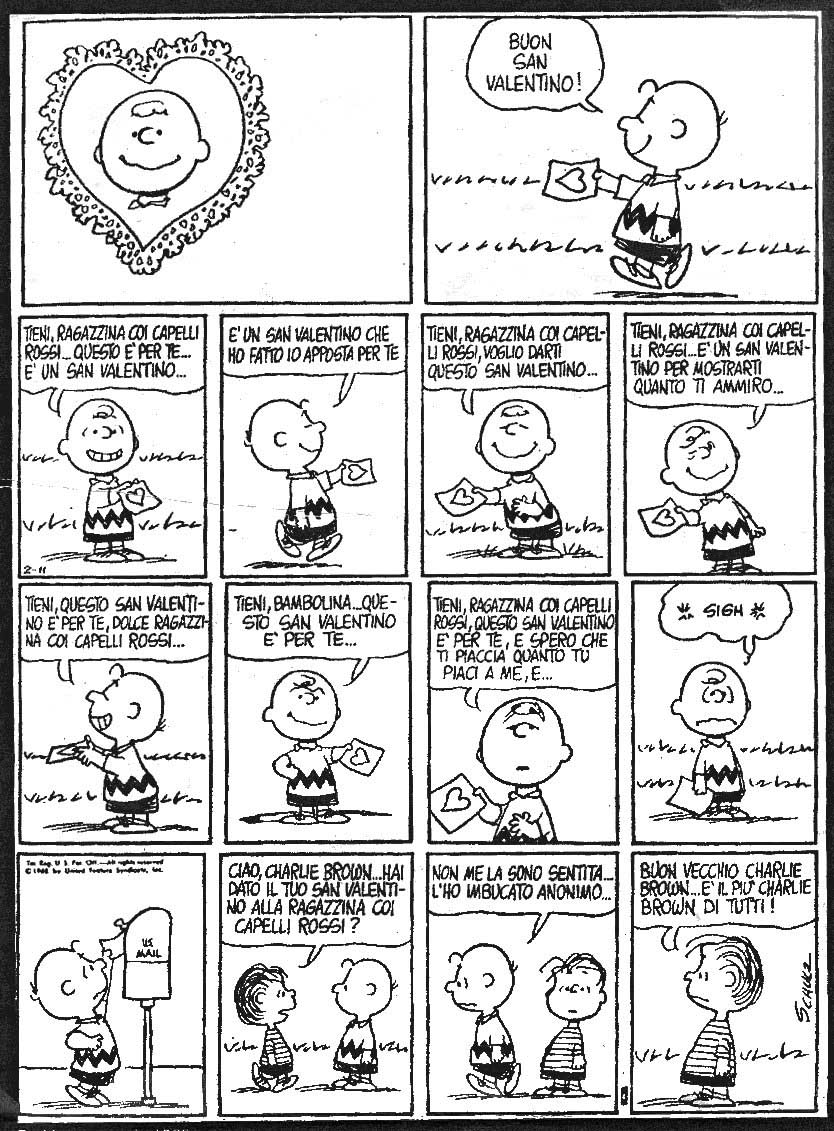
Era il maggio del
1968 quando sulle pagine di Linus fece la sua prima apparizione la
"ragazzina coi capelli rossi" attraverso le parole scritte,
pensate e sognate del timidissimo Charlie Brown.
Da allora in poi,
lungo trent’anni e rotti di Peanuts, possiamo solo affidarci alle
nostre arrugginite fantasie per immaginarla, perché la ragazzina coi
capelli rossi noi non l’abbiamo mai vista. Schulz, non l’ha mai
disegnata, né credo gli sia mai passato per la mente di disegnarla.
Dunque cosa sappiamo
di lei? Se non il fatto che abbia i capelli rossi, più le probabili
efelidi, anche se al momento non ricordo se il suo mentore Charlie Brown
ne abbia mai fatto cenno, per il resto non se ne sa nulla, nemmeno il
nome o il carattere. Per quanto ne sappiamo, anzi, potrebbe anche essere
il fantasma amoroso del suo piccolo innamorato che potrebbe averne
intuito la presenza dietro il vetro di uno scuola-bus fugace, oppure
averne sentito la voce dietro una di quelle staccionate che separano i
giardini delle villette americane. E, fortunatamente, non essendo mai
cresciuto Charlie Brown potrebbe anche non aver visto che dietro quella
staccionata non c’era niente da desiderare, nessuno da amare.
Accecati come siamo
dalla nostra rappresentazione di "adulti", molti di noi nel
leggere questa striscia si lasciano prendere da un leggero fremito di
rabbia, come per dire "Cristo Charlie Brown! Datti una
mossa!". E questo ruggito è di solito accompagnato da un sorriso
di indulgenza, ultimo lascito della nostra insopprimibile voglia di
inseguire quel che non c’è ma che non possiamo smettere di sognare,
desiderare, amare anche se non lo ammettiamo. Ma almeno, a quel punto,
sapremo ammettere quella mezza verità che soltanto nella solitudine di
noi stessi, quando non siamo troppo accecati dalla nostra
rappresentazione, siamo capaci di sussurrare: "Sono anch’io un po’
come Charlie Brown, ma non proprio come lui". E in effetti siamo
peggio.
Può apparire strano
come questo bambino dalla testa tonda abbia mantenuto intatta per mezzo
secolo la propria popolarità malgrado la sua immagine da perdente,
malgrado la sua mancanza di furbizia. Perché Charlie Brown non è furbo
ed è proprio vero che questa è una delle caratteristiche che ci
rendono simpatici alcuni bambini. Ed è altrettanto vero che in un mondo
ed in una cultura dominati dalla furbizia Charlie Brown dovrebbe
perdersi. Ma Charlie Brown non si perde. Non si perde perché in lui
rivive, e si rinnova, la magia dei Peanuts che sta proprio in questo
"non essere ancora" che risparmia ai bambini, e a noi eterni
bambini, la definitiva delusione dell’essere, del crescere e di tutto
ciò che sta dietro la staccionata.
D’altronde, cos’è
amare se non quest’altra lunga attesa?
Charlie Brown, senz’altro
il più saggio e il più maturo dei Peanuts, questo lo sa più di tutti,
sa più di tutti che il filo invisibile della speranza che ci lega a
ciò che non c’è, ma potrebbe essere, non va spezzato, mai.
Niente è ancora
avvenuto, nessun San Valentino ha centrato o mancato il suo bersaglio,
dunque tutto è ancora intero, intatto e può essere atteso, sognato nel
migliore dei sogni possibili. La ragazzina coi capelli rossi non ha mai
saputo, né saprà mai di Charlie Brown perché i Peanuts hanno chiuso e
la staccionata rimarrà sempre troppo alta per la sua statura.
Sarei tentato di
immaginare la ragazzina coi capelli rossi dentro una stanza di chat
qualunque ed il mio piccolo Charlie Brown che non osa aprire uno di quei
famosi mp, ma no, la ragazzina coi capelli rossi posso soltanto
immaginarla dentro un fumetto. Sempre bambina, sempre coi capelli rossi
che fruga nella cassetta delle lettere e trova un San Valentino anonimo
che le accende la vanità ma non brucia neppure una delle sue curiosità
sulla vita, sull’amore.
Allora prendo un
foglio di carta e ti scrivo: "Tieni ragazzina coi capelli rossi, un
buon San Valentino anonimo da tutti noi".
|
|
Sotto un cielo che
si apre e si chiude al ritmo di una fisarmonica c’è l’Inghilterra:
sobria e maestosa come il volto della Regina stampato sulle pesanti e
dorate sterline. A dire il vero delle vicende di Casa Reale sembra
importare più a noi italiani, poveri divoratori di soap-opera
giornalistiche, tanto che se provaste a ricordare ad un suddito di Sua
Maestà il motto "God save the Queen", questi assumerà
immediatamente quell’aria pensosa, sospesa tra il dubbio e l’indifferenza,
che in poche parole si riassume in un bel "Chissenefrega!".
Ma questi sono gli inglesi, gente che fondamentalmente pensa ai fatti
suoi e crede che la vita sia un’incredibile serie di coincidenze cui
non prestare molta attenzione, perché, in fin dei conti, basta saperle
vivere con l’ironica saggezza di aver visto tutto a questo mondo.
Incontrare un inglese significa ritrovarsi davanti una persona che
sembra essere capitata lì per caso o, meglio, di essere soltanto di
passaggio senza preoccuparsi molto di capire dove stia andando e dove
abbia intenzione di andare.
Son proprio fatti così, fin dal 1690 allorquando il diplomatico e
saggista inglese Sir William Temple nel suo saggio "Of poetry",
affermò che erano stati i suoi connazionali ad aver inventato lo
"humour", cioè quell’atteggiamento beffardo nei confronti
delle noie della vita quotidiana. Esso poteva fiorire soltanto in una
società libera come quella anglo-sassone e a dimostrazione di ciò fece
notare che le altre nazioni europee nemmeno hanno questa parola nei
vocabolari. Infatti "umore" in italiano e "humeur"
in francese hanno tutt’altro significato che in inglese si tradurrebbe
con "mood" o "disposition".
Ciò farebbe pensare alla lingua inglese come una lingua ricca di
sfumature verbali e lessicali ma, in realtà, esiste la convinzione, tra
gli studiosi di linguistica e della lingua inglese in generale, di come,
ad esempio, il verbo "to get", accoppiato a differenti
preposizioni, possa esprimere quasi tutte le azioni verbali e che
perciò si potrebbe fare a meno di studiare tutti gli altri verbi.
Le particolarità in Inghilterra non mancano: provate a guardare per
strada e vi sembrerà di vivere il mondo al contrario. Il senso di
disorientamento che si prova a guidare a sinistra è tale che voi non
riuscirete a capire in che direzione state andando, ed avrete la
sensazione di essere costantemente in corsia di sorpasso, ovvero di
essere fuori posto in un luogo dove il sole si potrebbe tranquillamente
confondere con la luna, dove la pioggia rende tutti un po’ malinconici
e irrimediabilmente pallidi.
Se poi voleste dare un colore a quest’isola questo sarebbe sicuramente
il verde: prati verdissimi ed immensi si apriranno dinanzi ai vostri
occhi, lasciandovi dentro la misteriosa ed insostenibile leggerezza di
essere veramente piccoli a questo mondo.
Ma sarà soprattutto il vostro fegato a diventare verde non appena
avrete assaggiato la bomba iperfritta del "fish’n chips" o i
famosi "haddock" che se vi azzardaste a consultare il
vocabolario Inglese-Italiano vi trovereste a leggere una definizione
alquanto sconcertante: "Eglefino".
Infine un avviso per tutti gli italiani che non sanno fare a meno della
nostalgia della propria lingua. Non provate a chiedere ad un inglese
"Do you speak Italian?" perché vi risponderebbe con una delle
pochissime parole di italiano conosciute in Inghilterra: "Vaffanculo!" |
|
7 maggio 1824.
Kärthner - Thor - Theater di Vienna.
Sul podio a dirigere
l’orchestra, che per la prima volta si apprestava ad eseguire la Nona
sinfonia in re min., un genio sordo, noto, al secolo ed a tutte le
future generazioni, col nome di Ludwig Van Beethoven, il Maestro,
forse il più grande. Da diversi anni ormai l’udito del compositore
era irrimediabilmente compromesso tanto che per comunicare con lui era
necessario scrivere sui famosi quaderni di conversazione. La direzione
dell’orchestra era, in realtà, affidata al primo violino Schuppanzig,
e soprattutto al maestro di cappella Umlauf, il quale tra l’altro
aveva dato ordine ai musicisti di ignorare i gesti del compositore.
La musica dunque iniziò e ciò che Beethoven aveva dinanzi agli occhi
si trasformava tra le pareti della sua mente in musica sublime, sognata
e vissuta quale unica via d’uscita da quell’ineffabile destino che
lo aveva avvolto in un silenzio irreale. Ecco, quella era la sua unica
certezza nel vedere un’orchestra che stava eseguendo note che
vibravano solo tra le pieghe della sua anima ed era una certezza che mai
lo aveva, e lo avrebbe, abbandonato in quell’itinerario terribile
della Nona Sinfonia, bilancio di una vita, fino ad esplodere nell’inno
alla gioia finale, che tradiva la sua immensa e generosa fiducia nell’uomo
invitandolo alla speranza, alla fraternità.
Improvvisamente i musicisti smisero di suonare ma lui, inconsapevole di
ciò che stava accadendo alle sue spalle, continuò a girare le pagine
del suo spartito e della sua mente, fino a quando la solista Unger scese
dal palco dei cantanti, abbracciò dolcemente Beethoven e lo girò verso
la platea: il pubblico era in delirio per quella che nei secoli e nei
secoli verrà celebrata come la sinfonia, una delle più grandi
opere che l’umanità avesse mai conosciuto.
Immagino Beethoven lasciarsi sfuggire un sorriso carico di gioia e
amarezza allo stesso tempo perché non si può non essere d’accordo
con il critico musicale Armando Torno quando scrive: "La Nona che
ascoltiamo nella realtà, con quei suoni che Beethoven si è immaginato
ed ha elaborato lentamente è forse altra cosa. La vera Nona la conobbe
soltanto lui e la suonò in sé e con sé mentre un’orchestra non
accettava i suoi ordini". Così si realizza un evidente paradosso:
se è vero che Beethoven non ebbe mai la soddisfazione di sentire
eseguite le sue ultime opere, è anche vero che forse il mondo non ha
mai conosciuto la musica che Beethoven compose nella sua mente.
Quella del lontano 7 maggio 1824 è una delle rarissime apparizioni in
pubblico del compositore nel suo ultimo decennio di vita, quello
maggiormente avvolto nel mistero, quando l’udito era soltanto un
terribile e doloroso ricordo che gli sventrava l’anima e lo rinchiuse
in una solitudine assoluta.
Mi son chiesto spesso, durante la mia lettura di appunti biografici su
Beethoven, se la sordità avesse in qualche modo inciso sulla sua opera,
e la risposta non può che essere positiva. Lo stesso M. Solomon nella
sua biografia sul compositore così scrive: "In quel suo mondo di
sordo, Beethoven potè sperimentare nuove forme di esperienza, libero
dai suoni invadenti dell’ambiente esterno, libero dai rigidi schemi
del mondo materiale, libero come un sognatore, di combinare e
ricombinare la sostanza della realtà, seguendo i propri desideri, in
forme prima inconcepibili"
Se basta chiudere gli occhi per immaginare cosa prova un cieco, non
sarà mai sufficiente tapparsi le orecchie per comprendere il mondo di
un sordo. La sordità è la condizione che più di ogni altra costringe
ad una continua ricerca introspettiva, venendo a mancare quel richiamo
costante alla realtà che filtra idee, pensieri e sensazioni. Si vive in
un universo di suoni e rumori immaginari, immersi in una realtà,
gigantesco acquario impazzito, che rischia essa stessa di divenire
immaginaria. Si è soli, dannatamente soli in un silenzio che offre
poche certezze e tanti tanti maledetti dubbi che martellano il cervello.
Ma questo la gente non lo sa e probabilmente non lo vuol sapere e allora
si deve o tacere o mentire, aggrappandosi ai propri ideali, se non si
vuole affondare per sempre negli abissi del silenzio.
Nel 1801 in una lettera al suo amico F.G. Wegeler, il trentunenne
Beethoven così scrive:
"Devo
confessare che la mia vita trascorre miseramente; da circa due
anni evito la vita di società perché non mi è possibile dire
alla gente: sono sordo".
Erano anni di grande
tormento che, unito al suo temperamento collerico, ne facevano emergere
un figura in lotta contro se stesso, irresistibilmente esposto alla
tentazione di arrendersi di fronte al rinnovarsi monotono delle
sofferenze, a quella solitudine esasperata.
Soltanto in altre due o tre lettere Beethoven accennò a quel calvario
che, usando le sue stesse parole, lo avrebbe privato della "parte
più nobile di se stesso". A partire dal 1810 non esiste alcuna
lettera o documento, in cui Beethoven faccia riferimento alla sua
avanzata sordità.
Aveva scelto di tacere.
La sua era una missione che non poteva fallire, non se lo sarebbe mai
perdonato. Guidato dalla sua straordinaria e, forse, ineguagliabile
sensibilità artistica realizzò un viaggio oltre il tempo ed oltre lo
spazio quale nessun altro artista, credo, riuscirà mai a realizzare. La
sua arte lo aveva salvato, consapevole che un giorno il suo genio gli
avrebbe reso tutto.
Si dice che Beethoven avesse segato le gambe del suo pianoforte e che
suonasse disteso con l’orecchio sul pavimento per carpire meglio le
vibrazioni, ma queste forse sono leggende destinate ad alimentare il
mito di un genio sordo che ha donato agli uomini una musica immortale.
Al contrario della sua musica, Beethoven incontrò la morte tre anni
dopo quel famoso 7 maggio 1824, in perfetta solitudine ed in linea col
suo destino di eroe tragico. Molti furono quelli che visitarono il
compositore nei suoi ultimi giorni di vita (fra questi F. Liszt,
Schubert, G. Rossini), ma pochi, pochissimi quelli che lo assistettero
nella sua triste dimora della Schwarzspanierhaus (Casa degli
Spagnoli neri). Tra quelle mura mi piace pensare che ancora oggi
riecheggino le parole del suo Testamento:
O uomini se
un giorno leggerete queste mie parole, ricordate che mi avete
fatto torto, e l‘infelice tragga conforto dal pensiero di aver
trovato un altro infelice che, nonostante tutti gli ostacoli
imposti dalla natura, ha fatto quanto era in suo potere per
elevarsi al rango degli artisti nobili e degli uomini degni.
|